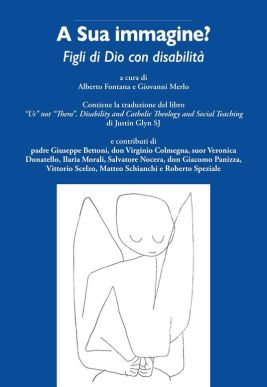
La copertina del libro “A Sua immagine? Figli di Dio con disabilità”
Troppo spesso, nel corso dei secoli, soprattutto nell’epoca pre-conciliare, la sofferenza, la malattia è stata intesa sia come esplicita conseguenza del peccato personale e di quello della famiglia d’origine del malcapitato, ma anche come generoso e puro dono di Dio.
Convinzioni che per molto tempo hanno nutrito l’esperienza di Dio di tanti e tante che nel corso della loro esistenza hanno avuto come orizzonte di senso per la loro vita proprio queste convinzioni, offerte loro quasi come verità di fede. L’alimentarsi di tali convinzioni è andato di pari passo con l’allontanamento dalla nuova logica evangelica inaugurata da Gesù.
«La tua sofferenza è ben accetta a Dio, è un dono che ti salva». È questa una delle espressioni che spesso chi scrive, su sedia a rotelle sin dalla nascita, ha ascoltato e si è sentito rivolgere da tanti e tante che all’interno della comunità ecclesiale ricoprono un particolare ruolo e svolgono svariati servizi. Nel mio animo più e più volte dunque si è fatto strada questo ragionamento: «Dio ama ricevere il dono della sofferenza dopo avertelo dato Lui per primo perché così salva il mondo. È il modo che Lui ha scelto per dimostrarti il suo amore. Ti ha unito alla sua passione, ti ha chiamato a condividere questa missione che ti apparterrà per sempre e solo quella».
Nel mentre, però, cercavo nel corso del tempo di accogliere questa verità, si faceva strada in me una lotta interiore contro quell’immagine di Dio che mi era stata presentata. No, non potevo amare Qualcuno che dimostrava il suo amore per me dandomi da vivere la malattia. Ne è nata una combattuta ma feconda riflessione su tale concezione.
Mi accorgevo infatti che la sofferenza poteva, in molti casi e anche nel mio, abbrutire la persona umana, renderla davvero mostruosa. Mi sono accorto che non è sempre vero che il dolore rende bella la persona. Esso invece la rende monca, ribelle, in rivolta con se stessa, con Dio e con gli altri.
Non c’è arte più difficile, infatti, dell’accompagnamento di una persona che vive un profondo dolore nella sua esistenza. In quel caso, quando la rabbia prende il sopravvento, sfigura la bellezza della propria umanità, l’annuncio della bellezza della vocazione del soffrire non solo non ha presa, ma è assolutamente deleteria e allontana da Dio, facendolo sentire nemico del bene della persona.
«A Dio non si offre qualcosa di cattivo»: è quanto ha affermato un malato di tumore in un’intervista rilasciata il 20 aprile 1988 alla testata «La Croix». Il prosieguo della sua risposta, nella medesima intervista, ci dà la possibilità di comprendere perché la disabilità non sia essa stessa una vocazione e cercheremo di capire come la vita con il proprio limite accolto e trasfigurato possa divenire dono d’amore; prosegue l’intervistato: «Cristo non ha offerto le sue sofferenze al Padre, ma gli ha offerto ciò che egli diventava in quelle sofferenze: un essere che andava fino in fondo, fino all’estremo, fino al punto più profondo dell’amore, fino a quei vertici di amore che sono capaci di salvare».
È l’amore che salva, non il dolore. Ci può essere amore nel dolore? Sì, nella misura in cui però non si riduce la propria esistenza al limite che si vive. Così è stato anche per l’esperienza di Gesù: «Non è la croce e non sono le sofferenze patite nella passione e sulla croce che hanno reso grande Gesù, ma è l’esatto contrario: è la vita di Gesù, l’intera vita di Gesù traversata dall’amore, spesa nell’amare che le ha dato senso anche a quell’abominio che era, che è e che sempre resterà la croce. […] quella morte diviene eloquente alla luce della vita precedente che la illumina con la luce dell’amore e della dedizione incondizionata agli altri. Il Cristo Signore, colui che è il “maestro buono” (Marco: 10,17), che ha amato i suoi fino all’estremo, fino al punto di non ritorno (cfr. Giovanni: 13,1), dà senso alla croce, ovvero anche alle sofferenze fisiche, psichiche e morali, che si sintetizzano nella realtà della croce. Cristo non ha offerto le sue sofferenze, ma ha offerto se stesso, ha fatto della sua vita un’offerta a Dio trovando la propria gioia nell’amare gli altri e questo l’ha fatto sempre, non solo sulla croce: la croce è il culmine di una vita spesa per gli altri nell’amore e nella dedizione» (citazione tratta da Luciano Manicardi, L’umano soffrire. Evangelizzare le parole della sofferenza, Edizioni Qiqajon, Magnano (Biella), 2006, pagina 176).
Concepire come salvifica l’offerta delle sofferenze a Dio da parte suoi figli, che pare Gli siano gradite, sconvolge l’immagine stessa di Dio, ma anche il fine di ogni esperienza umana, anche quella più tribolata. Prescindendo, invece, da questa logica asfittica, non evangelica e negativa per l’autentica e integrale promozione della persona umana, occorrerebbe inabissarsi per alcuni istanti nel mistero di Dio il quale non gioisce delle sofferenze, ma del dono d’amore che all’interno della tribolazione gli uomini e le donne da Lui creati e amati possono realizzare, cioè la loro vocazione.
È alla perla che nasce nell’ostrica attaccata dal mollusco che Dio guarda. È questa vita realizzata e fiorita nonostante il dolore che il Signore apprezza e che desidera che Gli sia offerta. È la vittoria della Pasqua, la forza della vita oltre tutto, il centro e il motore propulsivo dell’esistenza umana, non il dolore, non la morte.
Occorre dunque un cambio di paradigma dell’esperienza di Dio e di mentalità per le nostre comunità civili e religiose. Occorre che vi sia un forte scatto di reni affinché l’annuncio positivo del Vangelo, che innerva a suo modo ogni realtà sociale, giunga e scompigli le credenze antiche e paralizzanti, giungendo ad annunciare a coloro che vivono il limite della disabilità: «Tu non sei la tua disabilità».
La domanda da porsi, e su cui si gioca l’accompagnamento della Chiesa e dei tanti che si spendono accanto alle persone con disabilità, non è tanto «Perché la disabilità?», quanto invece «Cosa ne fai tu di questo limite? Come può fiorire la tua vita? Essa si ferma ad esso oppure può divenire luogo di rinascita, di forza, di lotta?».
Dio è sconfinato, scrive Elizabeth Green, teologa e pastora evangelica battista e dunque anche l’uomo e la donna, creati ad immagine della Sua sconfinatezza, hanno infinite possibilità per realizzare la propria esistenza smarcandosi dalla ghettizzazione pseudo teologica di esseri angelicati e predestinati alla macerazione interiore e fisica, intesa quale soave profumo gradito a un Dio che non è Padre. Il Dio di Gesù, infatti, è ben diverso; non dà una pietra a chi gli chiede il pane (cfr. Luca: 11,11-12).
Tanti potrebbero essere gli esempi al riguardo. Gesù stesso nei Vangeli dimostra di non essere felice del dolore umano, e agisce sempre guarendo dal di dentro la persona, talvolta indignandosi per le conseguenze sociali di quella sofferenza*.
Cosa fare allora? Se San Giovanni della Croce affermava che «amare Dio è spogliarsi per Dio di ciò che Dio non è», questa è dunque la vocazione di ogni cristiano, di ogni comunità, dalla più grande Chiesa locale al più sconosciuto dei cristiani e alla più sconosciuta delle cristiane.
Guardare all’umano e alle sue infinite possibilità di donarsi e di vivere: è ciò che dovrebbe fare ciascuno di noi. Soltanto partendo da questa convinzione potranno essere abbattute perfino le barriere architettoniche che sottintendono, anch’esse, l’idea che non tutti hanno il diritto di vivere con gli altri.
Nella vita c’è posto per tutti, e non per un atto di gentile concessione da parte di un Essere supremo o di un’istituzione, ma in forza del proprio essere uomini e donne, sia che possano camminare, vedere, parlare o meno. È la persona, intesa come un’unità complessa costituita da mente, corpo, anima che deve essere posta al centro di ogni azione sociale, civile ed ecclesiale. Soltanto così essa potrà portare il suo contributo al vivere civile ed ecclesiale.
Unicamente così ci sarà vera inclusione, solamente così si apriranno per la società sconfinate possibilità di crescita perché tutti, secondo la propria vocazione e i propri talenti non annientati dal proprio limite fisico, possano sempre più cantare la sconfinatezza della vita, ad immagine di Dio, sconfinato e liberante che chiama ciascuno a edificare una nuova umanità.
Questa è la vera vocazione di ogni essere umano, non la disabilità.
*Un episodio esemplificativo di ciò è l’incontro di Gesù con il lebbroso narrato in Marco 1,40-45. L’evangelista Marco narra che appena Gesù ebbe visto il lebbroso, provò un moto di indignazione, frammisto a dolore per la sua condizione fisica e sociale.
Nella colonnina a destra (Articoli correlati) del nostro articolo Comprendere una volta per tutte che non vi è distinzione tra “noi” e “loro” (a questo link) sono presenti tutti i testi già pubblicati in «Superando.it», che hanno preso spunto dal libro A Sua immagine? Figli di Dio con disabilità.
Il presente contributo è già apparso nel blog A Sua immagine? e viene qui ripreso per gentile concessione.


